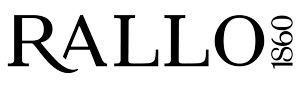Questo non è il mio vino di Andrea Vesco
Pochi comparti agro industriali sono affollati come quello enologico, e le motivazioni sono essenzialmente due: basse barriere all’ingresso e valore sociale riconosciuto a chi fa vino.
Produrre piccole quantità presso strutture terze con uve o vino non proprio è oggi piuttosto semplice, tanto in Sicilia quanto in altre regioni d’Italia.
Chiunque poi volesse investire nel settore della trasformazione troverebbe facile accesso a diversi aiuti finanziari.
La provvista comunitaria per aiutare i produttori primari a chiudere la filiera onde ottenere maggiore valore aggiunto, sembra essere inesauribile in barba alla legge fondante l’economia che vuole le risorse per definizione scarse.
La tecnologia per produrre un liquido idroalcolico che possa essere a diritto definito vino resta poi alla portata di tutti.
La spinta sociale, infine, vale a dire il riconoscimento del vicino che qualifica come migliore di sé perché dotato di fascino e ricco di mistero chiunque possa attribuirsi la paternità di una qualsiasi bottiglia, ha spinto un numero significativo di individui a cimentarsi nell’impresa e a diventare produttori, produttori di vino.
Il risultato è conseguenza delle premesse, d’altronde i sillogismi spiegano le realtà, non la inventano.
Da tali premesse non potevano che derivare le seguenti conclusioni: come tutti i mercati con basse barriere all’ingresso e a tecnologia diffusa ed economica, il profitto medio per singolo operatore, quando c’è, – e sono più gli operatori che non remunerano adeguatamente tutti i fattori della produzione, che quelli che lo fanno – è estremamente modesto.
In sintesi, il più delle volte l’impresa non riesce, o meglio sembrerebbe sempre essere sul punto di riuscire senza che mai riesca, dimensione questa, psicologicamente peggiore del fallimento pieno e conclamato.
Il fallimento è uno stato risolutivo, inaugura sempre una nuova possibilità, chiude e definisce un percorso, apre ad una prospettiva, conclude e dunque inaugura, “(…) il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire (…)” (Prospettiva Nevskij).
Se la spinta all’impresa agro industriale fosse solo orientata dal ritorno economico, tutto sommato gli effetti diffusi di questa condizione non sarebbero così deleteri, mentre invece subentrano sia l’aspetto personalistico che la complessità gestionale della produzione vitivinicola, con tutte le variabili della filiera, unite alla durissima competitività del mercato perennemente sovraffollato, aspetti questi che diventano un vero e proprio dramma collettivo caratterizzato da un perenne delirio narcisistico.
In sintesi, il mercato è uno spazio enorme ed affollatissimo nel quale quasi nessuno riesce a trovare reali elementi di autentica differenziazione, veri spazi identitari.
Nella nostra esistenza la madre accogliente riconosce e soddisfa, educa anche all’assenza, matrice teologica di autonomia e libertà.
Nel mondo professionale il mercato no, il mercato in cui opera il produttore di vino a volte lusinga ma non riconosce.
Il mercato semplifica, tende genericamente a includere in categorie omogenee, da qui i mestieri di “category manager” e “critici enogastronomici”. I primi operano nelle grandi strutture d’acquisto, sono signori che non guardano mai in viso, i secondi restituiscono, spesso a caro prezzo, l’identità perduta.
Da qui l’ipertrofia dell’io e l’inevitabile deriva narcisistica, ultima possibilità di apparente sopravvivenza. I’io elevato a garante della qualità del vino, del suo valore organolettico e commerciale rinuncia per sempre alla possibilità di contatto con il mondo, e diventato sigillo di qualità, da quel momento in poi, parlerà solo con se stesso, rifiutando ogni dialogo.
Il mio vino, le mie vigne, la mia ascendenza, il mio podere, mio padre, mia madre, i miei cani, le mie pratiche, le mie abitudini, le mie tecniche…
Diretta conseguenza di tutto questo sono le foto di famiglia, di primi piani in vigna con il vestito buono, quello in tinta con la stagione o con l’etichetta di nuova promozione, gli avi esposti a garanti di competenze che lungi dall’essere la sommatoria di studi pregressi ed esperienze consolidate negli errori superati e pagati, diventano parti di un fantomatico e presunto asse ereditario.
Tutta la retorica dell’io trova ampio spazio, ogni viticultore assorbito dal sistema diventa novello padreterno sulla volta della cappella Sistina, indirizzando con il proprio indice l’onnipotenza divina, conferisce al proprio mondo il valore universale del creato.
Ma se invece di limitare la costruzione del nostro mondo interiore alla sole radici giudaico cristiane avessimo la possibilità di spaziare anche nel patrimonio greco, ci tornerebbe subito familiare il mito dell’androgino di Platone, riecheggerebbero a monito di qualsiasi presunzione attuale le parole di Aristofane, e l’ermafrodito lungi dal rappresentare l’incarnazione del mostruoso bizzarro avrebbe il giusto valore del compiuto.
Il gioco, il divertimento dei bambini, la loro felicità, si interrompe nel momento in cui il primo del gruppo inizia a dire le parole io o mio, il mio interrompe, rompe l’armonia.
Il mondo del vino vive nella noia perché ritiene che alla base di ogni generazione di senso e di valore ci sia l’io e che tutto ciò che vale trae origine dalla forza idealizzata di una potenza creatrice, l’io, il mio, le mie idee…
Noioso e narciso sa solo parlare a sé stesso, riconosce unicamente il proprio volto nelle immagini irreali e patinate dei tabloid, il mondo fuori di sé non esiste se non nella misura in cui lo adula, lo eleva, nutre il suo patologico bisogno di riconoscimento che, un ambiente affollato e svalutante come quello in cui opera, tende inevitabilmente ad essere frustrato.
Ed allora la fine è segnata?
Il baratro inevitabile?
Il silenzio l’unica risposta possibile ad un mondo che non pone domande perché incapace di ascoltare qualsiasi risposta?
Forse no, l’arte e la letteratura, il bello ed il vero per definizione ci tendono una mano, ci indicano una direzione possibile, quella dell’assurdo.
Davanti al didascalismo delle immagini di regime, davanti agli abiti inamidati in vigna, ai divani sui prati o in bottaia con nonni e bambini esposti a garanti del nostro sangue e del nostro sperma, di nuovo dell’io e del mio, Magritte e la sua pipa, Foucault ed il pensiero del fuori aprono una breccia.
“Questo non è il mio vino” potrebbe essere il motto liberatorio ed alternativo per una viticultura autentica.
Coltivare il dialogo con tutte le entità emozionali che abitano le terre che conduciamo come quelle circostanti, amare, alla pari ulivi e roverelle, potrebbe essere un gesto rivoluzionario.
Ogni luogo ha un suo genio, ogni agricoltore mantiene con esso un dialogo ininterrotto, che cancellerebbe qualsiasi spinta motivazionale, ed allora il sipario calerebbe per sempre.